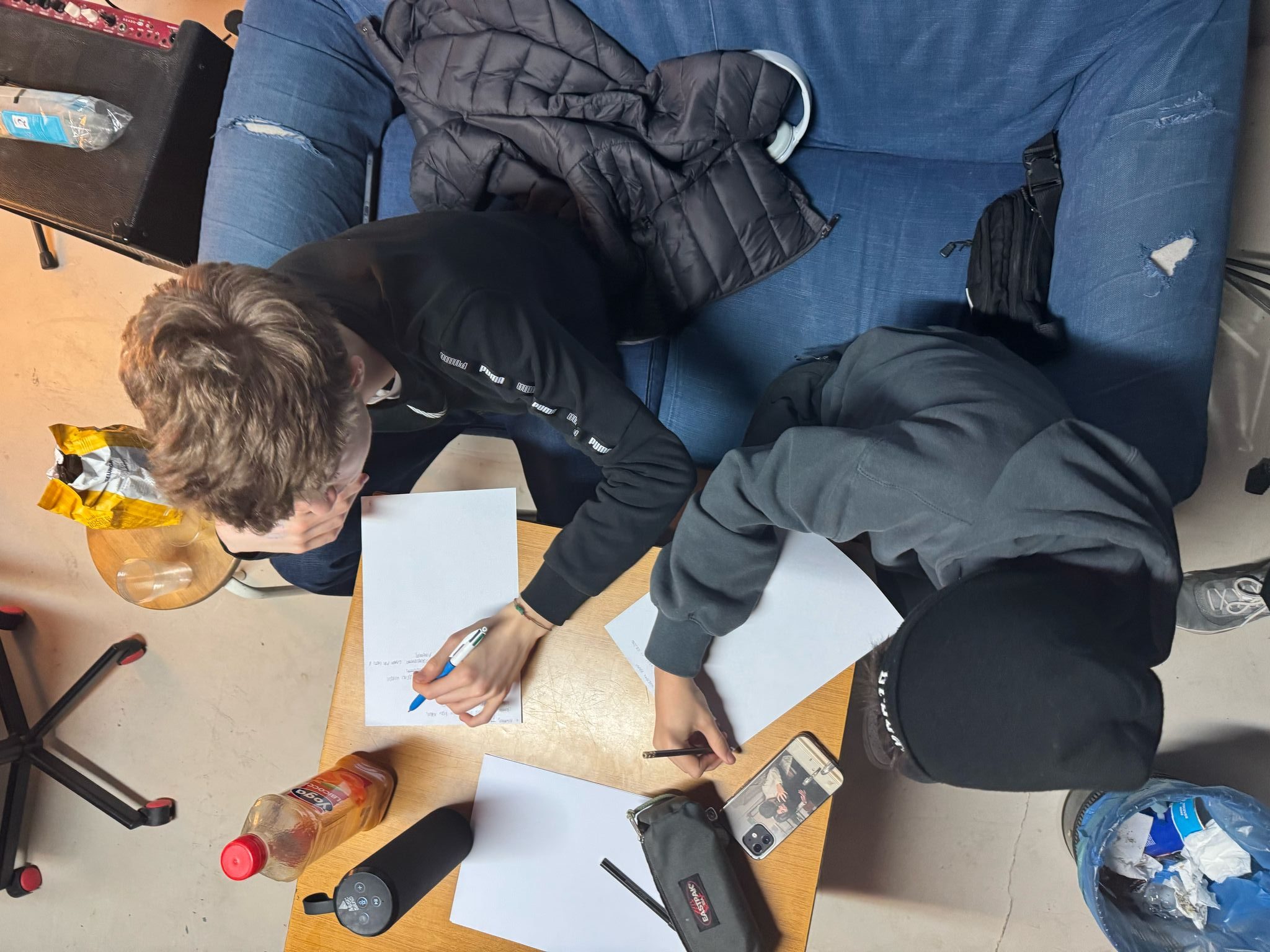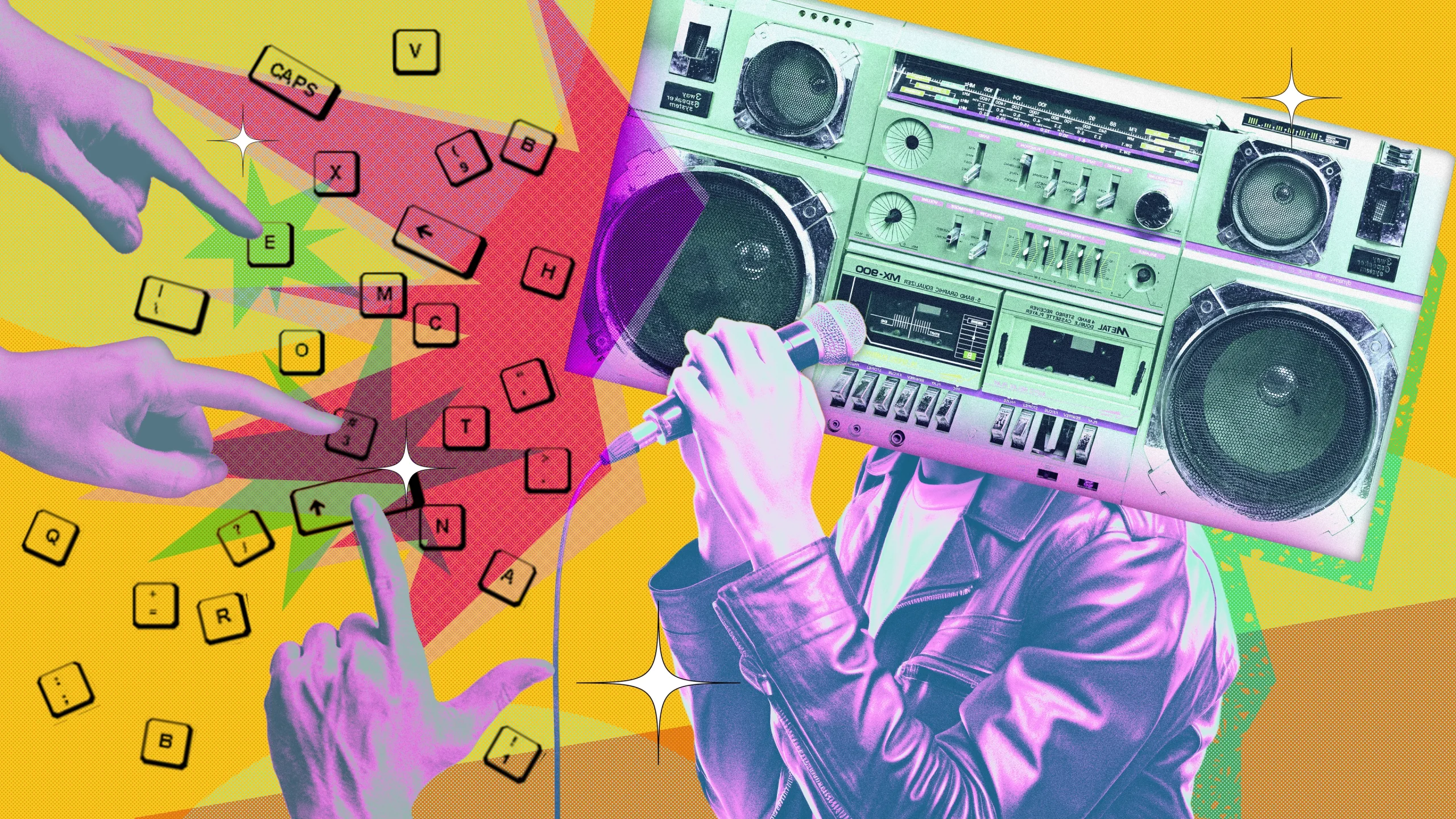
Nato nel Bronx come voce di riscatto, il rap oggi entra nei laboratori educativi di Milano, dando a ragazze e ragazzi uno spazio autentico di espressione. Nei testi emergono vissuti profondi, a volte inconsapevoli, che l’arte del rap riesce a liberare e trasformare in dialogo. E nell’epoca dell’intelligenza artificiale riaffiora la domanda cruciale: può un algoritmo replicare l’atto di dare voce a se stessi attraverso la musica?
«I ragazzi scrivono spessissimo e in modo molto genuino: utilizzando il loro linguaggio e lasciando emergere parti della loro vita o del loro modo di leggere la realtà che arricchiscono anche chi lo ascolta». Lo racconta Mattia Lista, l’educatore che ha guidato un laboratorio di rap nel territorio di Gorla-Turro, presso gli spazi del CAG Tempo per l’infanzia1, come parte del progetto SpinOff2, supportato dal Bando Terzo Settore di Regione Lombardia. L’obiettivo è stato condiviso: contrastare la povertà educativa dei cittadini tra i 12 e i 18 anni delle aree più periferiche e trascurate di Milano. E lo è stato anche il metodo: formare e stimolare in modo creativo, attraverso l’arte e il gioco, per ampliare il bagaglio culturale ed esperienziale degli adolescenti. Un percorso che dimostra quanto il rap possa essere un linguaggio da imparare, praticare e condividere. Per essere e sentirsi liberi.
Alle origini del rap
«Nel panorama musicale attuale il rap è sicuramente l’espressione artistica e narrativa più seguita e compresa dalla maggior parte del mondo occidentale, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi», spiega Lista. «Ogni generazione ha la propria cultura e questa ha scelto il rap».
Mattia Lista
Mattia Lista è un educatore professionale che lavora per la cooperativa “Tempo per l’infanzia”. Fondatore insieme ad altri educatori e professionisti del settore, nonché amici, dell’associazione 232 APS che usa lo strumento della musica rap per proporre laboratori educativi e musicali come veicolo di inclusione sociale e di libera espressione per adolescenti che frequentano comunità, centri di aggregazione giovanile, scuole o istituti penitenziari.
Il genere nasce nel Bronx degli anni ‘70-‘80, in un contesto di abbandono urbano e sociale3: «completamente apolitico, quando all’inizio degli anni 80 era finito quel sogno dell’inclusione che negli anni 70 si pensava fosse possibile», racconta Lista, «tutto e tutti erano rimasti abbandonati a se stessi, pieni di lavori iniziati, scuole e strade bloccate. Anche le case avevano perso valore e la gente iniziava a incendiarle per ricevere un indennizzo e potersi trasferire da un’altra parte. È proprio in questo contesto di degrado che nasce il rap, come gioco sì, ma soprattutto come senso di rivalsa».
Non è un caso che il termine stesso derivi dall’inglese antico rap, “colpire, battere”, presto associato anche al “parlare veloce” o al “confessare”. Nelle comunità afroamericane del Novecento questa parola si è poi trasformata in “discorso ritmato”, fino a identificarsi con il battito musicale4. Rap significa dunque, letteralmente, “parlare a ritmo”: un intreccio di voce e percussione verbale che trasforma la parola in suono e la narrazione in musica.
Non è un grido di ribellione aggressiva ma come una spinta verso l’integrazione. La sua forza sta nell’accessibilità: non pone barriere a chi si vuole avvicinare e non richiede competenze artistiche sofisticate.
«Il rap è immediato», spiega Lista «a differenza di tanti altri canali di espressione come la poesia, che contempla delle regole formali, non ha un canone rigido e non richiede una conoscenza linguistica approfondita».
Perché il rap a scuola
L’esperienza del laboratorio ha mostrato con chiarezza la potenza del rap: sciogliere in pensieri, concetti e vissuti, lasciandoli emergere in modo spontaneo e autentico. Talvolta in modo inconsapevole, ma sempre senza filtri. Dopo una breve introduzione tecnica, i partecipanti al laboratorio tenuto da Lista per SpinOff, hanno potuto scrivere in autonomia, vincolati da una sola regola: niente testi offensivi, sessisti o razzisti. Per il resto libertà assoluta. E quella libertà è stata colta fino in fondo: tutti hanno preso alla lettera la non-regola, stupendo Lista stesso che di laboratori di rap ne ha condotti a decine.
«Ci aspettavamo rime leggere, qualche verso d’amore, la “cotta per la tipa” e invece sono emersi temi profondi», racconta Laura Tanzi, coordinatrice del progetto e fondatrice di Lyra Teatro, felice che la scelta del rap si sia dimostrata vincente.
Lyra Teatro
Lyra Teatro è un’associazione milanese fondata nel 2012 che si dedica alla drammaturgia contemporanea, con produzioni originali come “Amorica” (2015), “Anti(Real)Gone” (2017) e “Bluebird” di Simon Stephens (2023). Dal 2017 al 2025 è attiva presso la Fabbrica del Vapore nell’ambito del progetto The Art Land, dove ha prodotto i propri spettacoli e organizzato le rassegne “Fabbricanti di mondi”, ospitando compagnie indipendenti da tutta Italia. Parallelamente all’attività teatrale, Lyra Teatro sviluppa progetti sociali innovativi come “La Fabbrica delle Culture”, utilizzando l’arte come strumento di inclusione e contrasto alla povertà educativa nelle periferie milanesi.
Scopri di piùVisita il sito ufficiale
Non è un caso, osserva Lista, che il rap si riveli uno strumento tanto versatile: funziona «sia in contesti di inclusione – per stranieri e per chi conosce poco la lingua – sia per ragazzi che hanno disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà di tipo sociale o espressivo».
Emblematica la trasformazione di «tantissime ragazze musulmane, inizialmente timide o scettiche e che hanno trovato, poi, un canale di espressione, uno spazio libero e sicuro, dove scrivere senza paura di sbagliare».
Ma un flusso creativo di tale intensità emotiva, resterebbe sterile, se non incontrasse qualcuno disposto ad accoglierlo. È qui che entra in gioco l’educatore: ascoltare, riconoscere e raccogliere quelle parole, che consentono di «accedere a ciò che molti ragazzi non oserebbero dire a voce». Lista, educatore per professione e per vocazione, racconta che «nei testi affiorano stereotipi inattesi e fragilità nascoste che poi diventano un’occasione di confronto su temi altrimenti difficili da affrontare e che, altrimenti, rimarrebbero invisibili». La musica, in questo senso, è per gli e le adolescenti un varco: «un canale che svela vissuti inesplorati e poco conosciuti», commenta Lista «e che, allo stesso tempo, offre un terreno di gioco condiviso, capace di rafforzare il legame di fiducia».
Tuttavia, ciò che nei laboratori appare evidente non trova la stessa accoglienza nei contesti istituzionali. Lo racconta Laura Tanzi, che ha voluto portare il rap dentro la sua “Fabbrica delle Culture”, scontrandosi con diffidenze e pregiudizi.
«Nelle scuole ho riscontrato un problema principale: il rap veniva bollato come attività diseducativa e guardato con sospetto tanto da alcune insegnanti quanto da molte famiglie», spiega Tanzi.
«Anche in spazi culturali che pensavamo più aperti e privi di pregiudizi, non sono mancati atteggiamenti di ostracismo. Ci siamo sentiti dire: “Non ci sono attività più consone per i ragazzi e le ragazze? Non vogliamo che lo spazio venga usato per questo”». Secondo Tanzi e il suo team, a chi lo osteggiava sfuggiva il cuore del progetto: il laboratorio non era un esercizio di moda giovanile, bensì un percorso artistico capace di tradurre l’esperienza individuale in parola condivisa, per restituire voce a chi ne resta privo.
Ti consigliamo di leggere
La rima che nessuna macchina può generare
L’arrivo dell’Intelligenza Artificiale ha aperto nuove questioni anche nell’ambito dell’espressione creativa, persino in territori liberi come il rap. Lista non la demonizza: strumenti di Large Language Model5 possono rivelarsi utili in altri contesti, ma non possono sostituire la scrittura personale quando l’obiettivo è dar voce a se stessi. «Il rap è un canale per liberare quello che tu hai dentro», riflette Lista. «Puoi scrivere il testo in qualsiasi lingua, anche in un italiano sgrammaticato, con poche o tante parole, fuori tempo o senza tempo, ma deve essere esattamente quello che tu vuoi dirmi». L’IA può certo aiutare a trovare una rima o superare un blocco, ma non restituisce l’impronta personale che rende ogni verso irripetibile. «C’è il rischio di perdere un grosso pregio della musica: l’autenticità della propria voce».
Durante il laboratorio, «qualcuno ha provato a usarla per la difficoltà di esprimere un certo concetto o per trovare una parola mancante», racconta Lista, ma l’esperienza ha dimostrato che:
«Anche i ragazzi che usano l’IA per altri obiettivi, capiscono che senza il gesto diretto della scrittura, il gioco perde senso e non è più divertente».
Lì dove il divertimento resta un ingrediente fondamentale nella formula del rap, sia quando visto come arte sia quando usato come strumento educativo e di crescita.
- Tempo per l’Infanzia e le sue attività https://www.tempoperlinfanzia.it ↩︎
- Il progetto SpinOff www.progettospinoff.org ↩︎
- Il rap dal Bronx a oggi https://www.mescalina.it/musica/special/14/04/2023/speciale-hip-hop ↩︎
- Per saperne di più sulle origini del rap, Benvenga, L. (2022). Hip-hop, identity, and conflict: Practices and transformations of a metropolitan culture. Frontiers in Sociology, 7. https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.993574 ↩︎
- Un Large Language Model (LLM), o modello linguistico di grandi dimensioni, è un tipo di Intelligenza Artificiale (IA) addestrato su quantità enormi di dati testuali per comprendere, elaborare e generare linguaggio umano in modo efficace. ↩︎