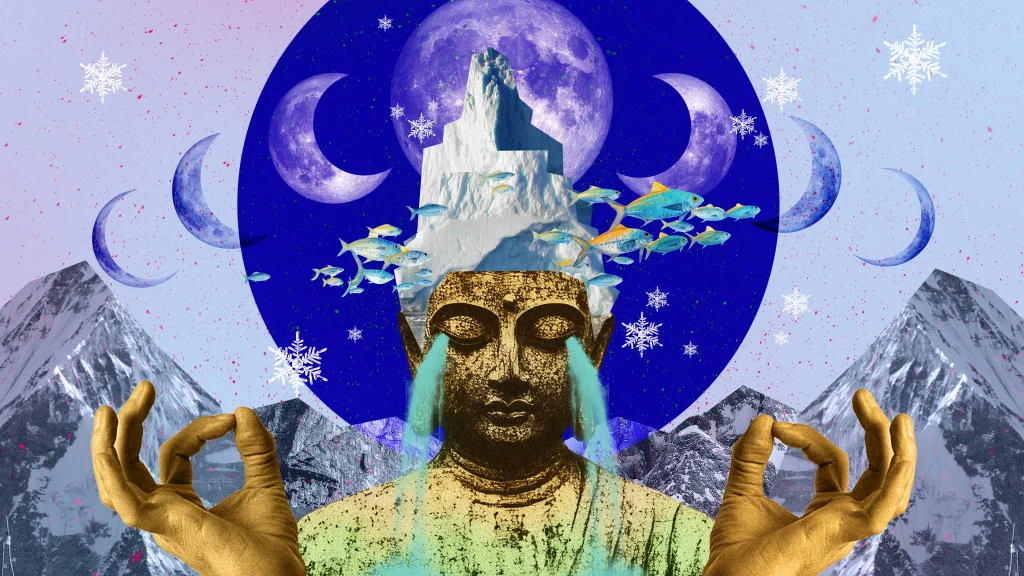Dai bot conversazionali alle piattaforme di deliberazione pubblica, dai toolkit creativi alle sperimentazioni sul campo, come si innescano i punti di svolta sociale? Il progetto europeo, coordinato dal Politecnico di Milano e animato da quindici partner europei, intreccia scienze sociali, tecnologia e partecipazione per capire come e quando le comunità decidono di cambiare rotta di fronte alla crisi climatica.
Ci sono momenti in cui la società cambia direzione improvvisamente. Accade quando una somma di piccoli gesti individuali raggiunge una massa critica e si trasforma in movimento collettivo. Gli studiosi li chiamano “social tipping points”1, punti di svolta sociale, e sono esattamente ciò che il progetto europeo NEUROCLIMA2 sta cercando di comprendere e attivare per accelerare la transizione climatica. Non è un’impresa semplice. La crisi del clima è ormai sotto gli occhi di tutti, eppure tradurre questa consapevolezza in azione quotidiana rimane una sfida. È qui che entra in gioco NEUROCLIMA, un progetto che unisce quindici partner da tutta Europa in un tentativo ambizioso: capire cosa spinge davvero le persone a cambiare comportamento e come questo cambiamento possa essere sostenuto, amplificato e replicato.
Una piattaforma che parla molte lingue
Il cuore tecnologico di NEUROCLIMA è una piattaforma digitale, attualmente in corso di sviluppo, articolata in diversi moduli che dialogano tra loro. Non un unico strumento, ma un ecosistema che si rimodella in base ai bisogni degli utenti e che bilancia tecnologia e sensibilità sociale, algoritmi e ascolto. All’interno della futura piattaforma convivranno un bot conversazionale capace di esplorare in tempo reale fonti qualificate – dalle policy europee agli articoli scientifici, dalle notizie ai contenuti multimediali – e uno spazio di apprendimento digitale che offre percorsi formativi su clima, comportamento e partecipazione civica. Accanto a questi strumenti, la piattaforma includerà spazi per la deliberazione pubblica, dove cittadini, esperti e decisori possono confrontarsi e co-progettare soluzioni, e una componente ludica che usa meccaniche di gioco per stimolare apprendimento e coinvolgimento emotivo.
Tutti questi strumenti che saranno sviluppati – come Lens, che raccoglie e analizza dati comportamentali, o Dialogues, spazio interattivo per discussioni partecipative, fino a Learn e Play, che trasformano l’apprendimento in esperienza creativa, e Repository, che custodisce conoscenze e risorse seguendo i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)3 – condivideranno un intento comune: rendere la conoscenza climatica più accessibile, esperienziale e riutilizzabile.
Quando il design incontra la psicologia
Ciò che distingue il progetto NEUROCLIMA non è tanto la varietà tecnologica, quanto l’intento di connettere le persone, trasformando dati e piattaforme in occasioni di dialogo. Non si tratta di sostituire l’interazione umana, bensì di amplificarla e sostenerla, creando ponti tra ricerca, istruzione e politiche pubbliche. Il progetto sta così sviluppando anche toolkit basati su design partecipativo – quell’approccio progettuale che coinvolge gli utenti finali nel processo di sviluppo – arti creative e cinematografia. Strumenti pensati per esplorare le dimensioni culturali ed emotive della transizione climatica. Perché la crisi del clima non è solo una questione di dati e grafici, ma di paure, speranze e identità collettive.
Tutti questi strumenti vengono co-progettati, «per garantire che siano accessibili, utili e radicati nei contesti reali», precisa Beatrice Gobbo, ricercatrice in Design presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, che guida la direzione scientifica, strategica e operativa dell’intero consorzio progettuale ma con un ruolo che va ben oltre la gestione amministrativa:
«Insieme ad altri partner, contribuiamo ad analizzare i processi di scaling, cioè come le innovazioni sociali e tecnologiche possano essere adattate e replicate in diversi contesti».
È una questione centrale, perché una soluzione che funziona a Milano potrebbe non avere lo stesso effetto ad Atene o a Stoccolma. Comprendere i meccanismi che permettono di trasferire e adattare queste innovazioni è parte integrante del progetto.
Le sperimentazioni previste da NEUROCLIMA coinvolgono due tipologie di pubblico molto diverse. Il primo pilota rivolto a policy maker e giornalisti, figure che hanno un ruolo cruciale nel tradurre la conoscenza scientifica in politiche pubbliche e narrativa mediatica.

Beatrice Gobbo, ricercatrice in Design presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, dove fa parte del team di coordinamento del progetto europeo NEUROCLIMA. È inoltre docente presso il Politecnico di Milano. Ha conseguito il dottorato in Design presso lo stesso Dipartimento, dove ha fatto parte del DensityDesign Lab. La sua ricerca si colloca all’incrocio tra information design, science and technology studies e informatica, con un’attenzione particolare al ruolo dei dati e delle rappresentazioni visive nei processi di conoscenza e decisione collettiva.
L’idea è testare come la piattaforma e gli strumenti di ricerca possano supportare una comunicazione più informata e partecipata sui temi climatici.
Il secondo pilota coinvolge invece studenti, docenti, cittadini ed educatori. Qui l’obiettivo è sperimentare la piattaforma, i toolkit e le attività creative in contesti educativi e comunitari. Non si tratta solo di verificare le prestazioni tecniche degli strumenti, ma di capire se riescono davvero a stimolare consapevolezza, dialogo e collaborazione. Aspetti fondamentali se si vuole che la transizione climatica sia qualcosa di condiviso e non imposto dall’alto.
Le persone al centro: il ruolo di IASIS
Mentre il Politecnico coordina la dimensione tecnologica e strategica, l’organizzazione greca IASIS si occupa della parte più direttamente legata alle persone. Come coordinatore del Work Package 34, IASIS ha il compito di collegare scienza comportamentale, partecipazione e creatività.
Stefanos Alevizos spiega che «esploriamo cosa motiva le persone ad agire, come le norme sociali e le emozioni plasmano l’adattamento, e come gli spazi di apprendimento possono supportare decisioni climatiche più inclusive».
È un approccio che parte da una constatazione semplice: non basta fornire informazioni corrette perché le persone cambino comportamento. Entrano in gioco fattori emotivi, sociali e culturali. Il modo in cui una comunità percepisce il rischio climatico dipende dalle sue esperienze concrete, dalle storie che circolano, dalle figure di riferimento. IASIS lavora proprio su questi aspetti, testando i metodi sviluppati in contesti locali reali e condividendo ciò che funziona.
«In IASIS vediamo il nostro ruolo come un ponte tra scienza e pratica quotidiana», continua Alevizos.
«Ci assicuriamo che ciò che viene appreso attraverso la ricerca diventi utile per cittadini, educatori e responsabili politici». È uno spirito di cooperazione che attraversa l’intero progetto: ogni partner contribuisce dal proprio campo di competenza e insieme costruiscono qualcosa che nessuno potrebbe realizzare da solo.
Gli strumenti per capire e agire
Gli strumenti di NEUROCLIMA «aiutano a collegare ricerca, istruzione e politiche in modo pratico e inclusivo», spiega Alevizos.

Stefanos Alevizos, psicologo e ricercatore post-dottorato presso l’Università Panteion, con quasi vent’anni di esperienza nel campo della salute mentale, della protezione dei minori e dei diritti umani. Ha coordinato iniziative nazionali ed europee volte a contrastare gli abusi sui minori, la violenza domestica e a promuovere l’inclusione sociale. In qualità di consulente scientifico presso l’ONG IASIS, contribuisce a progetti europei di ricerca e innovazione che collegano la scienza comportamentale, l’istruzione e la partecipazione della comunità. Il suo lavoro accademico si concentra sull’impatto psicologico dell’allontanamento dei minori a causa di abusi e sull’applicazione della psicologia forense alla protezione dei minori.
«Trasformano informazioni complesse in qualcosa che le persone possono utilizzare – per imparare, decidere e agire collettivamente, per una società più adattabile e resiliente». Il beneficio principale sta nel loro rendere l’azione climatica qualcosa di pratico, inclusivo e radicato nei comportamenti reali. Le comunità acquisiscono strumenti e spazi per discutere problemi locali e progettare le proprie risposte. Gli educatori ricevono materiali che rendono l’apprendimento climatico più interattivo e rilevante. I responsabili politici accedono a dati comportamentali che mostrano cosa motiva davvero le persone ad agire e come le politiche possano sostenere questo cambiamento.
Ma come si verifica che tutto questo funzioni davvero?
NEUROCLIMA utilizza un framework di science-of-scaling5: ogni strumento o metodo viene testato in contesti reali, monitorato attraverso indicatori comportamentali e perfezionato sulla base dei feedback raccolti. IASIS e gli altri partner raccolgono dati sia quantitativi che qualitativi, da sondaggi, workshop e progetti pilota locali, per capire cosa cambia realmente nella conoscenza, nelle emozioni e nelle azioni delle persone nel tempo. «Questo processo di apprendimento continuo garantisce che i risultati del progetto non siano solo promettenti sulla carta ma dimostrati per creare un impatto misurabile e duraturo nelle comunità e nelle istituzioni», conclude Alevizos. Perché alla fine, la vera sfida non è solo capire i social tipping points, ma farli accadere.
- Social tipping points: Kopp, R. E., Gilmore, E. A., Shwom, R. L., Adams, H., Adler, C., Oppenheimer, M., Patwardhan, A., Russill, C., Schmidt, D. N., & York, R. (2024). ‘Tipping points’ confuse and can distract from urgent climate action. Nature Climate Change, 15(1), 29–36. https://www.nature.com/articles/s41558-024-02196-8 ↩︎
- Neuroclima. The official website of the project https://neuroclima.eu/ ↩︎
- FAIR principles: https://www.go-fair.org/fair-principles/ ↩︎
- Work Package 3: Organisational structure of Horizon European projects, which divides activities into thematic packages. Horizon Europe. (2025, October 22). Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en ↩︎
- Science-of-scaling: Methodological framework for studying how innovations can be transferred and adapted on a large scale. ↩︎